RACCONTI
Giovanna Repetto
Il volto del padre
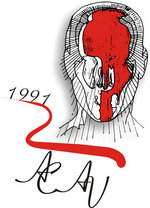
Da vecchio, in un tentativo di bilancio, posso dire che ho vissuto. Posso anche arrischiarmi a dire che, in una certa fase del mio percorso, sono diventato uomo. Non è facile per un essere umano diventare uomo. Non è facile diventare uomo senza padre. Non è facile diventare uomo nonostante il padre.
Di mio padre sapevo soltanto che era un medico, e che era morto in un incidente che aveva lasciato anche a me delle brutte cicatrici. Era accaduto quando avevo sei anni. Ma di quel fatto, e di tutta la mia vita precedente, non serbavo alcun ricordo. Da ragazzo ero affidato alle cure affettuose di una zia materna, nubile, che abitava in Provenza e che sembrava non aver altro scopo, nella sua vita, che quello di addolcire la mia. La mamma era morta qualche anno prima di mio padre. Ricordavo il suo viso in bianco e nero, esattamente come appariva nelle foto conservate da mia zia. Ma di mio padre non restava nessuna immagine.
Quando entrai nell'adolescenza avevo da un pezzo perso l'abitudine di far domande, perché le risposte di mia zia erano sempre state vaghe e rassicuranti. Avevo sedici o diciassette anni quando accaddero due episodi cruciali, l'uno di importanza evidente, l'altro insignificante solo in apparenza.
Era l'epoca dei miei primi amori, e un giorno fui sul punto di perdere la mia scomoda verginità con una coetanea. La ragazza era deliziosa sotto tutti i punti di vista. Era una parigina venuta a passare l'estate in Provenza, e il fatto che fosse lì di passaggio era per certi versi una circostanza facilitante. Avevamo preso l'abitudine di appartarci in un vecchio deposito di attrezzi da pesca poco lontano dal mare. Una barca ingombra di reti forniva un'alcova improvvisata.
In un caldo pomeriggio, mentre i grandi erano immersi nei loro sonnellini, ce ne stavamo là dentro, nudi e abbracciati, sopraffatti dall'emozione di un evento imminente. Mi venne da pensare che la ragazza era come un frutteto: la bocca color fragola, con un alito che profumava di mela, la pelle vellutata come una pesca. La sensazione di un miscuglio di fragranze mi diede un vago malessere, un capogiro che durò solo un momento. La stringevo al colmo dell'eccitazione, quando lei mi parlò in un sussurro, con una voce tenera che esprimeva più civetteria che paura: ti prego, non farmi male...
Chiusi gli occhi, come sommerso da un'onda, e subito scoppiai a piangere. Non capivo che cosa mi stesse accadendo, ma ogni eccitazione era svanita, e provavo solo angoscia e desolazione.
Qualche giorno dopo lei cercò ancora di avvicinarmi, mi disse che ero "complessato", e che voleva essermi d'aiuto. Si espresse con molta dolcezza, ma io la tenni lontana. Non fu tanto la vergogna, quanto il sentirmi sopraffatto da un male ignoto e molto più grande di me.
Il secondo episodio si svolse dentro un bar dove andavo spesso a prendere un gelato. Verso sera molti avventori si preparavano alla cena sorseggiando un aperitivo. Dalla porta aperta si affacciò un grosso cane irsuto, una specie di spinone di un indefinibile colore fra il marrone e il grigio. La vista di quella pelliccia mi ispirò subito un senso di repulsione misto a una vaga inquietudine. Dai commenti seppi che si trattava di un randagio che aveva l'abitudine di visitare il bar ogni mattina, in cerca di una brioche avanzata dal giorno precedente, che il proprietario gli teneva da parte.
Che c'è, Griffon? - domandò il barista con un ghigno - Hai sbagliato orario. Vuoi un aperitivo?
Indicava le bottiglie di liquori allineate con le loro etichette colorate bene in vista, e incitato dai lazzi e dalle risate dei clienti illustrava improbabili cocktail che il bastardo avrebbe potuto gradire. La nausea mi assalì imprevista, incoercibile. Corsi verso la toilette mentre già mi stavo vomitando addosso.
Cominciai ad avere degli incubi, dei quali al mattino non mi restava altro che un devastante senso d'angoscia.
Mi rendevo conto di quanto mi mancasse la guida di un padre, i suoi consigli. Magari per contestarli e fare di testa mia, ma sapendo con che cosa confrontarmi. Ripresi a fare domande. Possibile che non fosse rimasta nemmeno una foto di mio padre? Possibile sì, diceva mia zia, una volta non usava farsi fotografare tanto spesso. E poi, che cosa volevo vedere? Potevo stare tranquillo: mio padre era un bell'uomo, sano e robusto. E un po' gli somigliavo, anche se avevo preso il carattere della mamma. Non avevo motivo di non crederle, ma avevo bisogno di vedere il volto di mio padre: l'espressione, lo sguardo. Per poter immaginare il tipo d'uomo che era stato, e alimentare le mie fantasie.
E la casa dove avevo abitato con i miei genitori? Era stata venduta, per pagare il mio mantenimento. Del ricavato restava ancora un bel gruzzolo, di cui presto avrei potuto disporre. Che cosa volevo di più? E l'incidente... Non sapevo nulla dell'incidente che aveva ucciso mio padre, e in cui ero stato ferito. Per quanto ci pensassi non riuscivo ad evocare nemmeno un brandello di ricordo. Era bene così, mi diceva la zia. La mia amnesia era un dono della natura che aveva la funzione di proteggermi da brutti ricordi. E lei non avrebbe certo contrastato questo meccanismo provvidenziale. Quando insistevo fino a esasperarla finiva col dirmi che anche lei non ne sapeva molto.
Una mattina mi destai sudato, dopo aver sentito per tutta la notte i guaiti strazianti di un cane. Quando fui ben sveglio mi resi conto che si era trattato di un sogno. Questo non mi rallegrò. Da un po' di tempo i miei sogni cercavano di dirmi qualcosa.
A volte mi arrovellavo per cercare spiegazioni a fatti come quello del mio fallito approccio sessuale. Che cosa poteva avermi bloccato? La ragazza era consenziente: lo dimostravano, se non altro, la sua delusione e il successivo tentativo di recuperarmi. La sua frase non farmi male era probabilmente un modo per farmi apprezzare la sua verginità. Non farmi male. Forse la mia reazione aveva a che fare con l'incidente? Portavo ancora delle cicatrici sul corpo. Ero stato fortunato, in un certo senso, perché le ferite avevano risparmiato del tutto la testa e gli arti. Riguardavano solo parti del tronco, come l'addome e il torace. Sembrava strano restare feriti così in un incidente, quando si sa che le parti più esposte sono proprio la testa e gli arti.
Una notte ebbi un incubo che riuscii poi a ricordare appena sveglio. Sognai il cane che avevo visto nel bar. Si trascinava a fatica sul pavimento. Eravamo in una specie di cunicolo buio. Il pelo del cane era sporco e arruffato. Qualcuno mi stava dicendo che il cane si era ubriacato e che dovevo ucciderlo. Nell'aria stagnava un odore dolciastro. Io protestavo: forse il cane poteva guarire. No, non poteva, perché il liquore gli aveva scavato dei buchi nel corpo. Non c'era niente da fare. Un insopportabile senso di nausea mi pressava lo stomaco.
Nonostante le mie angosce superai a pieni voti l'esame per il diploma di scuola superiore. Insieme ai miei compagni festeggiai l'evento in trattoria. Ci servirono gli antipasti. L'oste, molto fiero di sé, ci strizzò l'occhio dicendo che ci avrebbe portato il suo pezzo forte, la sua specialità. Infatti ci presentò, su un grande tagliere, il suo famoso prosciutto di cinghiale. Il prosciutto di cinghiale non è liscio come quello di porco, ma si distingue perché il coscio è ricoperto ancora dalle setole dell'animale. Vidi quel coscio peloso, e il taglio rosso scuro della carne. Svenni ancor prima di potermi accorgere del malessere che mi aveva assalito. Gli amici dissero che mi ero già sbronzato con gli aperitivi, e fui contento di lasciarglielo credere.
Zia, mio padre andava a caccia? No, che io sappia, perché? Non c'è stato per caso un incidente di caccia? Non credo, ma poi che ne so, io abitavo in Provenza, lui in Bretagna, che ne sapevo di lui?
Finalmente avevo raggiunto la maggiore età, e potevo accedere a tutti i documenti di famiglia. Avrei saputo l'ubicazione della casa paterna, dove ero cresciuto nei miei primi sei anni. Avrei potuto mettermi in contatto con i nuovi proprietari e rivedere la casa. Forse questo mi avrebbe restituito la memoria. Forse sarei riuscito a ricordare il volto di mio padre.
Dovetti riconoscere che non ero ancora pronto per un viaggio così. Mi accontentai di andare a Marsiglia per cercare un'emeroteca. Dai documenti di successione avevo saputo l'esatta data della morte di mio padre.
Frequentavo spesso la città, dove l'amore mercenario mi consentiva esperienze altrimenti impossibili. Quel piccolo risarcimento in denaro, insieme all'anonimato, mi aveva aiutato a superare il mio blocco. Ma sarebbero passati ancora anni, ora lo so, prima di poter gustare le gioie della reciprocità amorosa.
Da quando ero riuscito a ricordare uno dei miei incubi, tenevo costantemente carta e penna sul comodino per prenderne nota al risveglio, ma non sempre mi riusciva di scrivere qualcosa di sensato. L'angoscia sì, persisteva intensa anche molte ore dopo il risveglio. Dovevo dunque cercare nella vita diurna le risposte ai miei interrogativi.
Alla biblioteca di Marsiglia non trovai subito quello che cercavo. All'epoca non era ancora possibile avvalersi degli strumenti informatici. Dovetti attendere che l'articolo mi arrivasse per posta. Era un semplice trafiletto, senza fotografia. Seppi così che mio padre era morto in auto, ma non per uno scontro. Semplicemente l'auto era esplosa, e il suo corpo si era consumato tra le fiamme. Si attribuiva la causa dell'incidente a sostanze chimiche che mio padre stava trasportando. En passant si diceva che egli era stato da tempo espulso dall'associazione nazionale dei ricercatori. Rilessi più volte l'articolo. Di me non c'era alcuna menzione. D'altra parte sembrava impossibile che qualcuno sopravvivesse a un incidente così. E le mie cicatrici?
Giocai d'astuzia con la zia, alla quale avevo nascosto accuratamente le mie ricerche. Le domandai dell'incidente e lei mi ripeté, come altre volte, che si era trattato di un incidente d'auto. E io dov'ero, zia? Eri su quell'auto, poverino, e sei rimasto ferito. Ora mi pareva chiaro che la zia mentiva. La guardai negli occhi e le dissi, dopo una pausa significativa: zia, io sto cominciando a ricordare qualcosa.
Impallidì, poi divenne rossa come il fuoco, si torse le mani e impallidì di nuovo. Sai, farfugliò, tuo padre... voleva tanto bene a te e alla tua mamma; quando lei è morta... be', dopo non è stato più lo stesso.
Non ci fu verso di cavarle altro. Dopo avermi fatto una rapida carezza, con le lacrime agli occhi scappò via e si chiuse in camera, borbottando che aveva mal di testa.
Una sera passeggiavo sulla spiaggia e guardavo il mare frangersi nei riflessi del tramonto. Mi venne incontro un vecchio che aveva fatto il pescatore per molti anni e poi, pensionato, aveva lasciato la barca per la canna. Si avviava con i suoi attrezzi verso il molo. Andate a pesca, Jacques? L'uomo sorrise con la bocca sdentata. Il nipotino, di sei o sette anni, lo accompagnava portando il secchiello con le esche. E pescherò molto bene, disse, perché stasera ho l'aiutante. Accarezzò la testa del bambino che mi guardava impettito. Eh sì, ripeté ridendo, questo è il mio aiutante!
Mi si riempirono gli occhi di lacrime per un'emozione improvvisa che non avrei saputo se definire piacevole o angosciosa. Senza più voce, li salutai con la mano. Il mio aiutante. Ero stato l'aiutante di mio padre? E in che cosa l'avevo aiutato?
La notte sognai, e questa volta sì, ricordai il mio sogno, benché avesse tanti aspetti confusi. Ero nel solito ambiente angusto e oscuro, appestato da un miscuglio di odori nauseabondi. Con me c'era Griffon, il cane del bar. Dovevamo andarcene, scappare. Vieni, Griffon, dobbiamo far presto. Il cane guaiva, ma non mi dava retta. Cercavo di tirarlo, ma il suo corpo era saldato al muro, anzi ad un blocco di pietra. Andiamo, presto, i gas ci uccideranno. Griffon piangeva e mi leccava le mani. Io lo tiravo con tutte le mie forze. Poi camminavo, e sentivo che stavo riuscendo a tirarmelo dietro. Voltandomi però mi accorgevo che aveva perso dei pezzi. Basteranno i pezzi che restano? Ce la farai, Griffon? Lui faceva segno di sì, ma solo per farmi contento. Si staccavano ancora altri pezzi, e Griffon non aveva più zampe, né schiena, né occhi. Neanch'io ce la farò, pensavo. Anch'io sono tutto a buchi.
Mi svegliai urlando, sudato, col respiro affannoso. Per fortuna la zia metteva tappi di cera per salvaguardare il suo sonno. Quando mi calmai, quando il cuore riprese un battito regolare e mi sentii certo di essere uscito dal sogno, pronunciai ad alta voce, con estrema sicurezza, le seguenti parole: non si chiamava Griffon, si chiamava Pierrot. Non ci fu verso di ricordare altro. Il viaggio in Bretagna non poteva più essere rimandato.
Avevo già preparato il terreno scrivendo ai nuovi proprietari della casa. Nella lettera esprimevo il desiderio di rivederla, e rafforzavo la motivazione spiegando che soffrivo di una rara forma di amnesia, e che a parere dei medici la visita ai miei luoghi d'origine mi sarebbe stata di grande aiuto. Mi risposero accogliendo di buon grado la mia richiesta. Tenni questo carteggio ben nascosto alla zia, giovandomi del fatto che m'ero incaricato sempre io di ritirare la posta dalla cassetta. Temevo che altrimenti la zia avrebbe tentato di ostacolarmi.
Ripensandoci oggi, sono certo che non mi sarebbe stato difficile farmi raccontare da lei l'intera faccenda, dopo averla messa al corrente degli indizi raccolti. Ma a quel tempo io non volevo soltanto sapere la verità. Volevo riavere indietro i miei ricordi.
Dissi che dovevo andare a Parigi per ragioni di studio, e tutto fu semplice. Dopo un giornata di viaggio raggiunsi Brest. Gettai solo un'occhiata distratta alle bellezze della costa. Ci sarebbe stato tempo dopo. Corsi alla casa di mio padre, dove i nuovi proprietari mi accolsero con cordiale curiosità. Dall'esterno la villa aveva un aspetto tetro. Dentro, il mobilio era stato in gran parte cambiato. Restava un vecchio camino, di cui comunque non mi ricordavo. Nell'insieme era un'abitazione grande e comoda, di una rassicurante banalità. Non c'era nulla che mi stimolasse la memoria. C'è altro? - domandai. Una soffitta, un sotterraneo? Sì, mi portarono a vedere la soffitta, e poi anche il sotterraneo. Una parte era adibita a cantina, il resto a magazzino. La soffitta era occupata da casse e bauli. Continuavo a domandare se non ci fosse altro. Un ripostiglio, un gazebo, una stanza non ancora visitata. Scuotevano il capo, rattristati dalla mia costernazione.
Fu uno dei ragazzi, che aveva dodici anni, che accennò alla "porta segreta". Che cos'era? Oh sì, una vecchia porta murata da sempre. I ragazzi stessi mi scortarono lungo un corridoio, per mostrarmi quel rettangolo nel muro, appena accennato, ma sufficiente a stuzzicare la loro fantasia. Non era possibile aprirla, se non con l'aiuto di un piccone. Scongiurai i padroni di casa, mi offrii di pagare tutte le spese e anche di più. Non ebbero cuore di rifiutare. Così fu chiamato un operaio che liberò la porta. Tutti si tirarono indietro, come assaliti da un improvviso timore. Da solo varcai la soglia.
Era lì. Era il posto dell'incubo. Uno scaffale polveroso copriva un'intera parete con una sfilata di flaconi di vetro scuro. Le etichette erano scritte a mano. Etere, cloroformio, disinfettanti, sostanze chimiche dai nomi astrusi. L'odore sembrava stagnare ancora nell'aria. C'era un tavolo di ferro. C'era un altro tavolo, da sala operatoria. C'era un lettino con le sponde a sbarre. C'era la gabbia dove mio padre teneva il randagio catturato per i suoi esperimenti.
Papà, che cosa fai? Vieni, caro, sarai il mio aiutante. Non fargli male, papà. E' per la scienza. L'avevo chiamato Pierrot perché aveva gli occhi tristi. Pierrot che guaiva, che mi leccava le mani. Pierrot crocifisso dai tubicini che gli trapassavano il corpo. Vedrai che guarirai, Pierrot. Ti farò uscire. Giocheremo, vedrai.
Ora i ricordi fluivano senza ostacoli, straripavano, uscivano dagli argini. Vedevo le mani di mio padre, belle mani eleganti, scorrere veloci lungo gli scaffali, a scegliere gli ingredienti giusti. Le vedevo frugare su un vassoio per scegliere i ferri. Sta' tranquillo, Pierrot, papà non ti farà male.
Sentivo la voce di mio padre. Figliolo, devi essere coraggioso. Figliolo, ho bisogno di te. Non farmi male, papà. Ti metterò un tubicino, ma piccolo. Non farmi male papà. La paura. Pierrot che ululava nella sua gabbia. Non è nulla, figliolo, devo studiare, capisci? Devo studiare le differenze. Si chiama fisiologia comparata. E' importante, capisci? Non farmi male. Non farmi male, papà. Non farci male. Pierrot piange. Senti come piange? Pierrot, non aver paura. Papà ci farà guarire e giocheremo insieme.
Figliolo, devo operarti di nuovo. Non è niente. Devo prelevare un pezzettino del tuo fegato. Solo un pezzetto. Non farmi male, papà. E' per la scienza.
Ora sì, ricordavo le lunghe notti, io e Pierrot soli all'inferno. Il suo respiro affannoso era l'unica compagnia. I suoi lamenti si mescolavano con i miei singhiozzi. Ti voglio bene, Pierrot. Sei il mio fratellino.
Ecco che mi risvegliavo dall'anestesia, una delle tante, con la bocca impastata e il naso impregnato di un odore disgustoso. Che cos'è questo rumore? Le mani di mio padre si muovevano rapide. Armate di una piccola mannaia, facevano a pezzi Pierrot sul tavolo di ferro. Vedevo il sangue sgorgare da quei pezzi di carne ancora coperti di pelo. Non farlo, papà. Ti prego, non farlo. Pierrot! Pierrot! Gridavo il nome del cane, come se la mia voce avesse il potere di farlo saltar fuori, vivo, per miracolo. Come se la scena potesse girare al contrario. E' per la scienza, figliolo. Papà, lo farai anche a me? Non farmi male, papà. Non farmi male. Non farmi male.
La memoria mi stava restituendo ogni cosa. Vedevo i piedi di mio padre calzati da scarpe eleganti, anche lì nel suo sudicio laboratorio. Vedevo i pantaloni scuri spuntare dal camice bianco. Le sue mani fini e agili, da artista. Il bavero del camice, il colletto della camicia. Devo essere uomo, pensai, e intanto singhiozzavo come un bambino. La memoria mi restituiva ogni cosa. Stavo per vedere il volto di mio padre.
Giovanna Repetto
Nata a Genova, si è trasferita da molti anni a Roma, dove vive e lavora come psicologa. Ama il teatro e gli animali. Fedelissima del Paradiso fin dall'inizio, nonché redattrice insostituibile, ha pubblicato romanzi e racconti, guadagnandosi anche qualche premio. Fra i romanzi: Palude abbracciami (Mobydick-2000), La gente immobiliare (Mobydick-2002), Cartoline da Marsiglia (Mobydick-2004).
Di mio padre sapevo soltanto che era un medico, e che era morto in un incidente che aveva lasciato anche a me delle brutte cicatrici. Era accaduto quando avevo sei anni. Ma di quel fatto, e di tutta la mia vita precedente, non serbavo alcun ricordo. Da ragazzo ero affidato alle cure affettuose di una zia materna, nubile, che abitava in Provenza e che sembrava non aver altro scopo, nella sua vita, che quello di addolcire la mia. La mamma era morta qualche anno prima di mio padre. Ricordavo il suo viso in bianco e nero, esattamente come appariva nelle foto conservate da mia zia. Ma di mio padre non restava nessuna immagine.
Quando entrai nell'adolescenza avevo da un pezzo perso l'abitudine di far domande, perché le risposte di mia zia erano sempre state vaghe e rassicuranti. Avevo sedici o diciassette anni quando accaddero due episodi cruciali, l'uno di importanza evidente, l'altro insignificante solo in apparenza.
Era l'epoca dei miei primi amori, e un giorno fui sul punto di perdere la mia scomoda verginità con una coetanea. La ragazza era deliziosa sotto tutti i punti di vista. Era una parigina venuta a passare l'estate in Provenza, e il fatto che fosse lì di passaggio era per certi versi una circostanza facilitante. Avevamo preso l'abitudine di appartarci in un vecchio deposito di attrezzi da pesca poco lontano dal mare. Una barca ingombra di reti forniva un'alcova improvvisata.
In un caldo pomeriggio, mentre i grandi erano immersi nei loro sonnellini, ce ne stavamo là dentro, nudi e abbracciati, sopraffatti dall'emozione di un evento imminente. Mi venne da pensare che la ragazza era come un frutteto: la bocca color fragola, con un alito che profumava di mela, la pelle vellutata come una pesca. La sensazione di un miscuglio di fragranze mi diede un vago malessere, un capogiro che durò solo un momento. La stringevo al colmo dell'eccitazione, quando lei mi parlò in un sussurro, con una voce tenera che esprimeva più civetteria che paura: ti prego, non farmi male...
Chiusi gli occhi, come sommerso da un'onda, e subito scoppiai a piangere. Non capivo che cosa mi stesse accadendo, ma ogni eccitazione era svanita, e provavo solo angoscia e desolazione.
Qualche giorno dopo lei cercò ancora di avvicinarmi, mi disse che ero "complessato", e che voleva essermi d'aiuto. Si espresse con molta dolcezza, ma io la tenni lontana. Non fu tanto la vergogna, quanto il sentirmi sopraffatto da un male ignoto e molto più grande di me.
Il secondo episodio si svolse dentro un bar dove andavo spesso a prendere un gelato. Verso sera molti avventori si preparavano alla cena sorseggiando un aperitivo. Dalla porta aperta si affacciò un grosso cane irsuto, una specie di spinone di un indefinibile colore fra il marrone e il grigio. La vista di quella pelliccia mi ispirò subito un senso di repulsione misto a una vaga inquietudine. Dai commenti seppi che si trattava di un randagio che aveva l'abitudine di visitare il bar ogni mattina, in cerca di una brioche avanzata dal giorno precedente, che il proprietario gli teneva da parte.
Che c'è, Griffon? - domandò il barista con un ghigno - Hai sbagliato orario. Vuoi un aperitivo?
Indicava le bottiglie di liquori allineate con le loro etichette colorate bene in vista, e incitato dai lazzi e dalle risate dei clienti illustrava improbabili cocktail che il bastardo avrebbe potuto gradire. La nausea mi assalì imprevista, incoercibile. Corsi verso la toilette mentre già mi stavo vomitando addosso.
Cominciai ad avere degli incubi, dei quali al mattino non mi restava altro che un devastante senso d'angoscia.
Mi rendevo conto di quanto mi mancasse la guida di un padre, i suoi consigli. Magari per contestarli e fare di testa mia, ma sapendo con che cosa confrontarmi. Ripresi a fare domande. Possibile che non fosse rimasta nemmeno una foto di mio padre? Possibile sì, diceva mia zia, una volta non usava farsi fotografare tanto spesso. E poi, che cosa volevo vedere? Potevo stare tranquillo: mio padre era un bell'uomo, sano e robusto. E un po' gli somigliavo, anche se avevo preso il carattere della mamma. Non avevo motivo di non crederle, ma avevo bisogno di vedere il volto di mio padre: l'espressione, lo sguardo. Per poter immaginare il tipo d'uomo che era stato, e alimentare le mie fantasie.
E la casa dove avevo abitato con i miei genitori? Era stata venduta, per pagare il mio mantenimento. Del ricavato restava ancora un bel gruzzolo, di cui presto avrei potuto disporre. Che cosa volevo di più? E l'incidente... Non sapevo nulla dell'incidente che aveva ucciso mio padre, e in cui ero stato ferito. Per quanto ci pensassi non riuscivo ad evocare nemmeno un brandello di ricordo. Era bene così, mi diceva la zia. La mia amnesia era un dono della natura che aveva la funzione di proteggermi da brutti ricordi. E lei non avrebbe certo contrastato questo meccanismo provvidenziale. Quando insistevo fino a esasperarla finiva col dirmi che anche lei non ne sapeva molto.
Una mattina mi destai sudato, dopo aver sentito per tutta la notte i guaiti strazianti di un cane. Quando fui ben sveglio mi resi conto che si era trattato di un sogno. Questo non mi rallegrò. Da un po' di tempo i miei sogni cercavano di dirmi qualcosa.
A volte mi arrovellavo per cercare spiegazioni a fatti come quello del mio fallito approccio sessuale. Che cosa poteva avermi bloccato? La ragazza era consenziente: lo dimostravano, se non altro, la sua delusione e il successivo tentativo di recuperarmi. La sua frase non farmi male era probabilmente un modo per farmi apprezzare la sua verginità. Non farmi male. Forse la mia reazione aveva a che fare con l'incidente? Portavo ancora delle cicatrici sul corpo. Ero stato fortunato, in un certo senso, perché le ferite avevano risparmiato del tutto la testa e gli arti. Riguardavano solo parti del tronco, come l'addome e il torace. Sembrava strano restare feriti così in un incidente, quando si sa che le parti più esposte sono proprio la testa e gli arti.
Una notte ebbi un incubo che riuscii poi a ricordare appena sveglio. Sognai il cane che avevo visto nel bar. Si trascinava a fatica sul pavimento. Eravamo in una specie di cunicolo buio. Il pelo del cane era sporco e arruffato. Qualcuno mi stava dicendo che il cane si era ubriacato e che dovevo ucciderlo. Nell'aria stagnava un odore dolciastro. Io protestavo: forse il cane poteva guarire. No, non poteva, perché il liquore gli aveva scavato dei buchi nel corpo. Non c'era niente da fare. Un insopportabile senso di nausea mi pressava lo stomaco.
Nonostante le mie angosce superai a pieni voti l'esame per il diploma di scuola superiore. Insieme ai miei compagni festeggiai l'evento in trattoria. Ci servirono gli antipasti. L'oste, molto fiero di sé, ci strizzò l'occhio dicendo che ci avrebbe portato il suo pezzo forte, la sua specialità. Infatti ci presentò, su un grande tagliere, il suo famoso prosciutto di cinghiale. Il prosciutto di cinghiale non è liscio come quello di porco, ma si distingue perché il coscio è ricoperto ancora dalle setole dell'animale. Vidi quel coscio peloso, e il taglio rosso scuro della carne. Svenni ancor prima di potermi accorgere del malessere che mi aveva assalito. Gli amici dissero che mi ero già sbronzato con gli aperitivi, e fui contento di lasciarglielo credere.
Zia, mio padre andava a caccia? No, che io sappia, perché? Non c'è stato per caso un incidente di caccia? Non credo, ma poi che ne so, io abitavo in Provenza, lui in Bretagna, che ne sapevo di lui?
Finalmente avevo raggiunto la maggiore età, e potevo accedere a tutti i documenti di famiglia. Avrei saputo l'ubicazione della casa paterna, dove ero cresciuto nei miei primi sei anni. Avrei potuto mettermi in contatto con i nuovi proprietari e rivedere la casa. Forse questo mi avrebbe restituito la memoria. Forse sarei riuscito a ricordare il volto di mio padre.
Dovetti riconoscere che non ero ancora pronto per un viaggio così. Mi accontentai di andare a Marsiglia per cercare un'emeroteca. Dai documenti di successione avevo saputo l'esatta data della morte di mio padre.
Frequentavo spesso la città, dove l'amore mercenario mi consentiva esperienze altrimenti impossibili. Quel piccolo risarcimento in denaro, insieme all'anonimato, mi aveva aiutato a superare il mio blocco. Ma sarebbero passati ancora anni, ora lo so, prima di poter gustare le gioie della reciprocità amorosa.
Da quando ero riuscito a ricordare uno dei miei incubi, tenevo costantemente carta e penna sul comodino per prenderne nota al risveglio, ma non sempre mi riusciva di scrivere qualcosa di sensato. L'angoscia sì, persisteva intensa anche molte ore dopo il risveglio. Dovevo dunque cercare nella vita diurna le risposte ai miei interrogativi.
Alla biblioteca di Marsiglia non trovai subito quello che cercavo. All'epoca non era ancora possibile avvalersi degli strumenti informatici. Dovetti attendere che l'articolo mi arrivasse per posta. Era un semplice trafiletto, senza fotografia. Seppi così che mio padre era morto in auto, ma non per uno scontro. Semplicemente l'auto era esplosa, e il suo corpo si era consumato tra le fiamme. Si attribuiva la causa dell'incidente a sostanze chimiche che mio padre stava trasportando. En passant si diceva che egli era stato da tempo espulso dall'associazione nazionale dei ricercatori. Rilessi più volte l'articolo. Di me non c'era alcuna menzione. D'altra parte sembrava impossibile che qualcuno sopravvivesse a un incidente così. E le mie cicatrici?
Giocai d'astuzia con la zia, alla quale avevo nascosto accuratamente le mie ricerche. Le domandai dell'incidente e lei mi ripeté, come altre volte, che si era trattato di un incidente d'auto. E io dov'ero, zia? Eri su quell'auto, poverino, e sei rimasto ferito. Ora mi pareva chiaro che la zia mentiva. La guardai negli occhi e le dissi, dopo una pausa significativa: zia, io sto cominciando a ricordare qualcosa.
Impallidì, poi divenne rossa come il fuoco, si torse le mani e impallidì di nuovo. Sai, farfugliò, tuo padre... voleva tanto bene a te e alla tua mamma; quando lei è morta... be', dopo non è stato più lo stesso.
Non ci fu verso di cavarle altro. Dopo avermi fatto una rapida carezza, con le lacrime agli occhi scappò via e si chiuse in camera, borbottando che aveva mal di testa.
Una sera passeggiavo sulla spiaggia e guardavo il mare frangersi nei riflessi del tramonto. Mi venne incontro un vecchio che aveva fatto il pescatore per molti anni e poi, pensionato, aveva lasciato la barca per la canna. Si avviava con i suoi attrezzi verso il molo. Andate a pesca, Jacques? L'uomo sorrise con la bocca sdentata. Il nipotino, di sei o sette anni, lo accompagnava portando il secchiello con le esche. E pescherò molto bene, disse, perché stasera ho l'aiutante. Accarezzò la testa del bambino che mi guardava impettito. Eh sì, ripeté ridendo, questo è il mio aiutante!
Mi si riempirono gli occhi di lacrime per un'emozione improvvisa che non avrei saputo se definire piacevole o angosciosa. Senza più voce, li salutai con la mano. Il mio aiutante. Ero stato l'aiutante di mio padre? E in che cosa l'avevo aiutato?
La notte sognai, e questa volta sì, ricordai il mio sogno, benché avesse tanti aspetti confusi. Ero nel solito ambiente angusto e oscuro, appestato da un miscuglio di odori nauseabondi. Con me c'era Griffon, il cane del bar. Dovevamo andarcene, scappare. Vieni, Griffon, dobbiamo far presto. Il cane guaiva, ma non mi dava retta. Cercavo di tirarlo, ma il suo corpo era saldato al muro, anzi ad un blocco di pietra. Andiamo, presto, i gas ci uccideranno. Griffon piangeva e mi leccava le mani. Io lo tiravo con tutte le mie forze. Poi camminavo, e sentivo che stavo riuscendo a tirarmelo dietro. Voltandomi però mi accorgevo che aveva perso dei pezzi. Basteranno i pezzi che restano? Ce la farai, Griffon? Lui faceva segno di sì, ma solo per farmi contento. Si staccavano ancora altri pezzi, e Griffon non aveva più zampe, né schiena, né occhi. Neanch'io ce la farò, pensavo. Anch'io sono tutto a buchi.
Mi svegliai urlando, sudato, col respiro affannoso. Per fortuna la zia metteva tappi di cera per salvaguardare il suo sonno. Quando mi calmai, quando il cuore riprese un battito regolare e mi sentii certo di essere uscito dal sogno, pronunciai ad alta voce, con estrema sicurezza, le seguenti parole: non si chiamava Griffon, si chiamava Pierrot. Non ci fu verso di ricordare altro. Il viaggio in Bretagna non poteva più essere rimandato.
Avevo già preparato il terreno scrivendo ai nuovi proprietari della casa. Nella lettera esprimevo il desiderio di rivederla, e rafforzavo la motivazione spiegando che soffrivo di una rara forma di amnesia, e che a parere dei medici la visita ai miei luoghi d'origine mi sarebbe stata di grande aiuto. Mi risposero accogliendo di buon grado la mia richiesta. Tenni questo carteggio ben nascosto alla zia, giovandomi del fatto che m'ero incaricato sempre io di ritirare la posta dalla cassetta. Temevo che altrimenti la zia avrebbe tentato di ostacolarmi.
Ripensandoci oggi, sono certo che non mi sarebbe stato difficile farmi raccontare da lei l'intera faccenda, dopo averla messa al corrente degli indizi raccolti. Ma a quel tempo io non volevo soltanto sapere la verità. Volevo riavere indietro i miei ricordi.
Dissi che dovevo andare a Parigi per ragioni di studio, e tutto fu semplice. Dopo un giornata di viaggio raggiunsi Brest. Gettai solo un'occhiata distratta alle bellezze della costa. Ci sarebbe stato tempo dopo. Corsi alla casa di mio padre, dove i nuovi proprietari mi accolsero con cordiale curiosità. Dall'esterno la villa aveva un aspetto tetro. Dentro, il mobilio era stato in gran parte cambiato. Restava un vecchio camino, di cui comunque non mi ricordavo. Nell'insieme era un'abitazione grande e comoda, di una rassicurante banalità. Non c'era nulla che mi stimolasse la memoria. C'è altro? - domandai. Una soffitta, un sotterraneo? Sì, mi portarono a vedere la soffitta, e poi anche il sotterraneo. Una parte era adibita a cantina, il resto a magazzino. La soffitta era occupata da casse e bauli. Continuavo a domandare se non ci fosse altro. Un ripostiglio, un gazebo, una stanza non ancora visitata. Scuotevano il capo, rattristati dalla mia costernazione.
Fu uno dei ragazzi, che aveva dodici anni, che accennò alla "porta segreta". Che cos'era? Oh sì, una vecchia porta murata da sempre. I ragazzi stessi mi scortarono lungo un corridoio, per mostrarmi quel rettangolo nel muro, appena accennato, ma sufficiente a stuzzicare la loro fantasia. Non era possibile aprirla, se non con l'aiuto di un piccone. Scongiurai i padroni di casa, mi offrii di pagare tutte le spese e anche di più. Non ebbero cuore di rifiutare. Così fu chiamato un operaio che liberò la porta. Tutti si tirarono indietro, come assaliti da un improvviso timore. Da solo varcai la soglia.
Era lì. Era il posto dell'incubo. Uno scaffale polveroso copriva un'intera parete con una sfilata di flaconi di vetro scuro. Le etichette erano scritte a mano. Etere, cloroformio, disinfettanti, sostanze chimiche dai nomi astrusi. L'odore sembrava stagnare ancora nell'aria. C'era un tavolo di ferro. C'era un altro tavolo, da sala operatoria. C'era un lettino con le sponde a sbarre. C'era la gabbia dove mio padre teneva il randagio catturato per i suoi esperimenti.
Papà, che cosa fai? Vieni, caro, sarai il mio aiutante. Non fargli male, papà. E' per la scienza. L'avevo chiamato Pierrot perché aveva gli occhi tristi. Pierrot che guaiva, che mi leccava le mani. Pierrot crocifisso dai tubicini che gli trapassavano il corpo. Vedrai che guarirai, Pierrot. Ti farò uscire. Giocheremo, vedrai.
Ora i ricordi fluivano senza ostacoli, straripavano, uscivano dagli argini. Vedevo le mani di mio padre, belle mani eleganti, scorrere veloci lungo gli scaffali, a scegliere gli ingredienti giusti. Le vedevo frugare su un vassoio per scegliere i ferri. Sta' tranquillo, Pierrot, papà non ti farà male.
Sentivo la voce di mio padre. Figliolo, devi essere coraggioso. Figliolo, ho bisogno di te. Non farmi male, papà. Ti metterò un tubicino, ma piccolo. Non farmi male papà. La paura. Pierrot che ululava nella sua gabbia. Non è nulla, figliolo, devo studiare, capisci? Devo studiare le differenze. Si chiama fisiologia comparata. E' importante, capisci? Non farmi male. Non farmi male, papà. Non farci male. Pierrot piange. Senti come piange? Pierrot, non aver paura. Papà ci farà guarire e giocheremo insieme.
Figliolo, devo operarti di nuovo. Non è niente. Devo prelevare un pezzettino del tuo fegato. Solo un pezzetto. Non farmi male, papà. E' per la scienza.
Ora sì, ricordavo le lunghe notti, io e Pierrot soli all'inferno. Il suo respiro affannoso era l'unica compagnia. I suoi lamenti si mescolavano con i miei singhiozzi. Ti voglio bene, Pierrot. Sei il mio fratellino.
Ecco che mi risvegliavo dall'anestesia, una delle tante, con la bocca impastata e il naso impregnato di un odore disgustoso. Che cos'è questo rumore? Le mani di mio padre si muovevano rapide. Armate di una piccola mannaia, facevano a pezzi Pierrot sul tavolo di ferro. Vedevo il sangue sgorgare da quei pezzi di carne ancora coperti di pelo. Non farlo, papà. Ti prego, non farlo. Pierrot! Pierrot! Gridavo il nome del cane, come se la mia voce avesse il potere di farlo saltar fuori, vivo, per miracolo. Come se la scena potesse girare al contrario. E' per la scienza, figliolo. Papà, lo farai anche a me? Non farmi male, papà. Non farmi male. Non farmi male.
La memoria mi stava restituendo ogni cosa. Vedevo i piedi di mio padre calzati da scarpe eleganti, anche lì nel suo sudicio laboratorio. Vedevo i pantaloni scuri spuntare dal camice bianco. Le sue mani fini e agili, da artista. Il bavero del camice, il colletto della camicia. Devo essere uomo, pensai, e intanto singhiozzavo come un bambino. La memoria mi restituiva ogni cosa. Stavo per vedere il volto di mio padre.
Giovanna Repetto
Nata a Genova, si è trasferita da molti anni a Roma, dove vive e lavora come psicologa. Ama il teatro e gli animali. Fedelissima del Paradiso fin dall'inizio, nonché redattrice insostituibile, ha pubblicato romanzi e racconti, guadagnandosi anche qualche premio. Fra i romanzi: Palude abbracciami (Mobydick-2000), La gente immobiliare (Mobydick-2002), Cartoline da Marsiglia (Mobydick-2004).
CERCA
NEWS
-
4.04.2025
Adelphi
Rosa Matteucci -
27.03.2025
Sellerio
Uwe Timm -
27.03.2025
Nutrimenti
Fabrizia Ramondino
RECENSIONI
-
Francesco Troccoli
Dugo e le stelle
-
Fred Vargas
Sulla pietra
-
Giulia Funiciello
L’Eletta. La leggenda di Alice Tempesta.
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
HENRY PURCELL 1659 – 1695
-
Stefano Torossi
Jean Sibelius 1865 - 1957
-
Marco Minicangeli
BookClub "Di Mercoledì"
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
marco minicangeli
La fossa delle Marianne
-
marco minicangeli
The Shrouds
-
marco minicangeli
Una barca in giardino
RACCONTI
-
Valentina Casadei
Diciotto metri quadrati.
-
Leonello Ruberto
Dispositivi mobili
-
Sara Calzolari
Quella volta il vento...

