CLASSICI
Alffredo Ronci
Un romanzo “complicato”: “Memorie di un presbiterio” di Emilio Praga e Roberto Sacchetti.
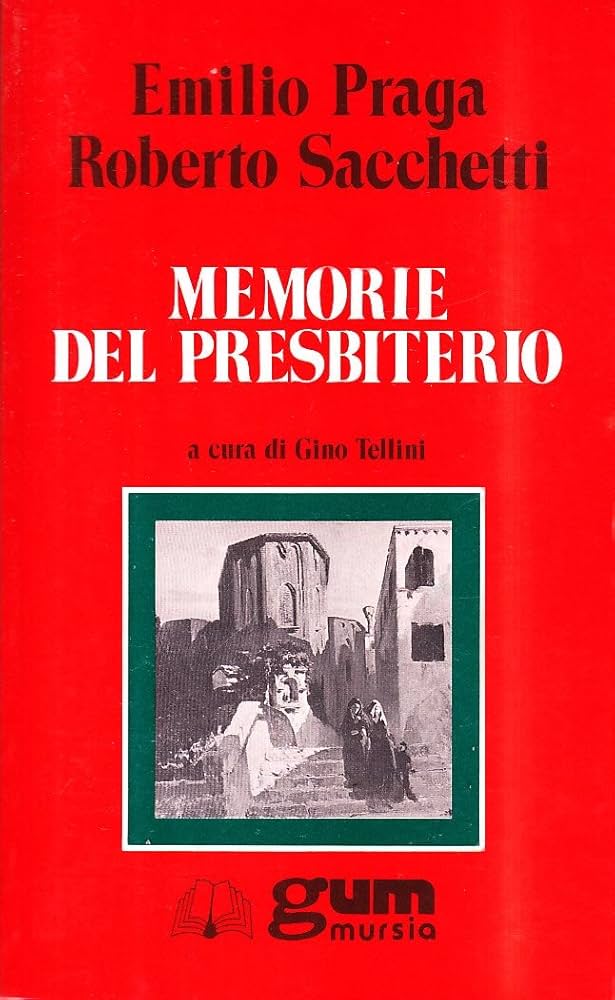
Romanzo che viene solitamente attribuito a Emilio Praga ma che in realtà, per la morte di costui, è stato terminato da Roberto Sacchetti. E fin qui, nonostante certa noncuranza di alcuni editori, nulla di male. In realtà però il male c’è (relativamente, ovvio).
Intanto Praga scriveva: Prendo anzi quest’occasione per ripetere ch’io qui non scrivo un romanzo col suo principio, col suo messo, col suo fine, colle sue cause, il suo sviluppo e le sue conseguenze, e tutte le belle cose che si leggono nei trattati di estetica; ma bensì raccolgo impressioni di scene e di fatti, sensazioni di luoghi e di persone in cui mi sono scontrato e che, per un mero effetto del caso convergono, se mi si presta attenzione, a far cornice utile se non anche necessaria al soggetto doloroso che è la ragione di essere di questo studio.
Naturalmente a parlare è il giovane pittore, protagonista della storia, ma ovviamente l’estensore delle note è il Praga. Cosa ci vuole aldunque dire? Sicuramente, al di là delle criticità di allora, il Praga vuole costruire un romanzo che si adatti ad un vasto pubblico e ricorre a espedienti che in qualche modo si rifanno a romanzo d’oltralpe e agli ingredienti tipici del feuilleton che si possono tranquillamente toccare con mano (qualcuno ha addirittura fatto riferimenti al Poe). Non solo, certe tipologie di alcuni personaggi, soprattutto femminili, rispondono ad alcune regole di cliché del romanzo ottocentesco (sposa virtuosa, l’orfanello angariato e anche una ballerina di provincia).
Ma la storia vuole anche essere un luogo non ligio agli schemi convenuti della moralità estetica tradizionale. Vuole essere bizzarra, impertinente, scapestrata ma anche scabrosa. Fuori semmai da ogni misura. E qui ritorniamo al quesito iniziale: c’è del male in questo sottile processo?
Praga scrisse il romanzo diciamo a metà, l’altra fu completata dal Sacchetti. Quanto di quello prescritto dal Praga poi fu realizzato e quanto invece fu distorto dal risolutore? I due scrittori si conoscevano bene e il fatto che il Sacchetti si adoperò a terminarlo in qualche modo ci fa pensare che quasi nulla fu “inventato” (forse non c’entra niente, anzi diciamo che proprio non c’entra un accidente, ma tra i due c’è anche una certa affinità del trapasso: Praga morì, assai giovane, nel 1875, il Sacchetti morì qualche anno dopo, nel 1881).
Dice, a proposito, Gino Tellini, il curatore dell’edizione che andiamo curando: La struttura dell’opera comprende così al proprio interno una serie concentrica di microromanzi che sono variazioni su uno stesso tema: si segmentano intersecandosi l’uno con l’altro e si frantumano interferendo spesso con il piano primario della “memoria” di Emilio.
Dunque per il Tellini, non sarebbe nemmeno “discriminatorio” pensare alle Memorie come un unico romanzo, come un’unica costruzione che al di là di certi rilasciamenti feuilletonistici, presentava anche degli indizi tutto sommato innovativi.
E quali erano? 0vvio che se si discute di un’opera letteraria ci sembra doveroso, proprio perché il costrutto del romanzo è pieno di elementi anche innovativi, riportare brevi cenni della trama.
Sullo sfondo apparentemente idilliaco di un piccolo Paese delle Alpi, in mezzo ad un crocevia di elementi da cliché naturalistici, un piccolo pittore italiano, di cui non si sa il nome ma che con precisione racconta gli avvenimenti, si trova a fare i conti con una vicenda del tutto curiosa e anche pregna di violenza e di angoscia. I personaggi di questa storia sono molteplici, dal sindaco al farmacista, dal semplice operaio, alla bella signora, da un ragazzo maltrattato e ad un parroco del paese, ma ben presto, per una sorta di avvenimento “giallo” (lo hanno detto altri critici, non noi, per una volta tanto), i protagonisti, nella loro storia di amplessi e di corna, si ritrovano in due (in realtà sono sempre tanti i big della vicenda, ma per razionalizzarla preferiamo indicare i principali): don Luigi, il parroco, e la bella Rosilde.
E’ inutile aggiungere altro, oltre che dispendioso rovinerebbe l’eventuale lettore che decidesse di confrontarsi con una storia che da più di qualcuno è stata definita arditamente innovativa, ma certamente le nostre posizioni e il fatto che nella fase conclusiva della vicenda si parla di amplessi, di corna e soprattutto di un parroco, tutto fa pensare a dei risvolti quanto meno inediti.
Non siamo di fronte ad un Manzoni, e nemmeno alle storie di feuilleton più innovative, ma certo Memorie del presbiterio ha qualcosa di profondamente strutturale. E diverso.
Fate voi.
L’edizione da noi considerata è:
Emilio Praga/Roberto Sacchetti
Memorie del presbiterio
Mursia
Intanto Praga scriveva: Prendo anzi quest’occasione per ripetere ch’io qui non scrivo un romanzo col suo principio, col suo messo, col suo fine, colle sue cause, il suo sviluppo e le sue conseguenze, e tutte le belle cose che si leggono nei trattati di estetica; ma bensì raccolgo impressioni di scene e di fatti, sensazioni di luoghi e di persone in cui mi sono scontrato e che, per un mero effetto del caso convergono, se mi si presta attenzione, a far cornice utile se non anche necessaria al soggetto doloroso che è la ragione di essere di questo studio.
Naturalmente a parlare è il giovane pittore, protagonista della storia, ma ovviamente l’estensore delle note è il Praga. Cosa ci vuole aldunque dire? Sicuramente, al di là delle criticità di allora, il Praga vuole costruire un romanzo che si adatti ad un vasto pubblico e ricorre a espedienti che in qualche modo si rifanno a romanzo d’oltralpe e agli ingredienti tipici del feuilleton che si possono tranquillamente toccare con mano (qualcuno ha addirittura fatto riferimenti al Poe). Non solo, certe tipologie di alcuni personaggi, soprattutto femminili, rispondono ad alcune regole di cliché del romanzo ottocentesco (sposa virtuosa, l’orfanello angariato e anche una ballerina di provincia).
Ma la storia vuole anche essere un luogo non ligio agli schemi convenuti della moralità estetica tradizionale. Vuole essere bizzarra, impertinente, scapestrata ma anche scabrosa. Fuori semmai da ogni misura. E qui ritorniamo al quesito iniziale: c’è del male in questo sottile processo?
Praga scrisse il romanzo diciamo a metà, l’altra fu completata dal Sacchetti. Quanto di quello prescritto dal Praga poi fu realizzato e quanto invece fu distorto dal risolutore? I due scrittori si conoscevano bene e il fatto che il Sacchetti si adoperò a terminarlo in qualche modo ci fa pensare che quasi nulla fu “inventato” (forse non c’entra niente, anzi diciamo che proprio non c’entra un accidente, ma tra i due c’è anche una certa affinità del trapasso: Praga morì, assai giovane, nel 1875, il Sacchetti morì qualche anno dopo, nel 1881).
Dice, a proposito, Gino Tellini, il curatore dell’edizione che andiamo curando: La struttura dell’opera comprende così al proprio interno una serie concentrica di microromanzi che sono variazioni su uno stesso tema: si segmentano intersecandosi l’uno con l’altro e si frantumano interferendo spesso con il piano primario della “memoria” di Emilio.
Dunque per il Tellini, non sarebbe nemmeno “discriminatorio” pensare alle Memorie come un unico romanzo, come un’unica costruzione che al di là di certi rilasciamenti feuilletonistici, presentava anche degli indizi tutto sommato innovativi.
E quali erano? 0vvio che se si discute di un’opera letteraria ci sembra doveroso, proprio perché il costrutto del romanzo è pieno di elementi anche innovativi, riportare brevi cenni della trama.
Sullo sfondo apparentemente idilliaco di un piccolo Paese delle Alpi, in mezzo ad un crocevia di elementi da cliché naturalistici, un piccolo pittore italiano, di cui non si sa il nome ma che con precisione racconta gli avvenimenti, si trova a fare i conti con una vicenda del tutto curiosa e anche pregna di violenza e di angoscia. I personaggi di questa storia sono molteplici, dal sindaco al farmacista, dal semplice operaio, alla bella signora, da un ragazzo maltrattato e ad un parroco del paese, ma ben presto, per una sorta di avvenimento “giallo” (lo hanno detto altri critici, non noi, per una volta tanto), i protagonisti, nella loro storia di amplessi e di corna, si ritrovano in due (in realtà sono sempre tanti i big della vicenda, ma per razionalizzarla preferiamo indicare i principali): don Luigi, il parroco, e la bella Rosilde.
E’ inutile aggiungere altro, oltre che dispendioso rovinerebbe l’eventuale lettore che decidesse di confrontarsi con una storia che da più di qualcuno è stata definita arditamente innovativa, ma certamente le nostre posizioni e il fatto che nella fase conclusiva della vicenda si parla di amplessi, di corna e soprattutto di un parroco, tutto fa pensare a dei risvolti quanto meno inediti.
Non siamo di fronte ad un Manzoni, e nemmeno alle storie di feuilleton più innovative, ma certo Memorie del presbiterio ha qualcosa di profondamente strutturale. E diverso.
Fate voi.
L’edizione da noi considerata è:
Emilio Praga/Roberto Sacchetti
Memorie del presbiterio
Mursia
CERCA
NEWS
-
27.03.2025
Sellerio
Uwe Timm -
27.03.2025
Nutrimenti
Fabrizia Ramondino -
28.02.2025
Nutrimenti
Novità.
RECENSIONI
-
Marco Azzalini
La notte ha il suo profumo
-
William S. Burroughs
Il gatto che è in noi
-
Marco Niro
L'uomo che resta
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Jean Sibelius 1865 - 1957
-
Marco Minicangeli
BookClub "Di Mercoledì"
-
Stefano Torossi
Ottorino Respighi
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
marco minicangeli
Una barca in giardino
-
Marco Minicangeli
La gita scolastica
-
Marco Minicangeli
Juniper - Un bicchiere di gin
RACCONTI
-
Leonello Ruberto
Dispositivi mobili
-
Sara Calzolari
Quella volta il vento...
-
Ersilia Tomoe
L'appartamento

