CLASSICI
Alfredo Ronci
Una scrittrice forse incompresa: “Ieri” di Delia Benco.
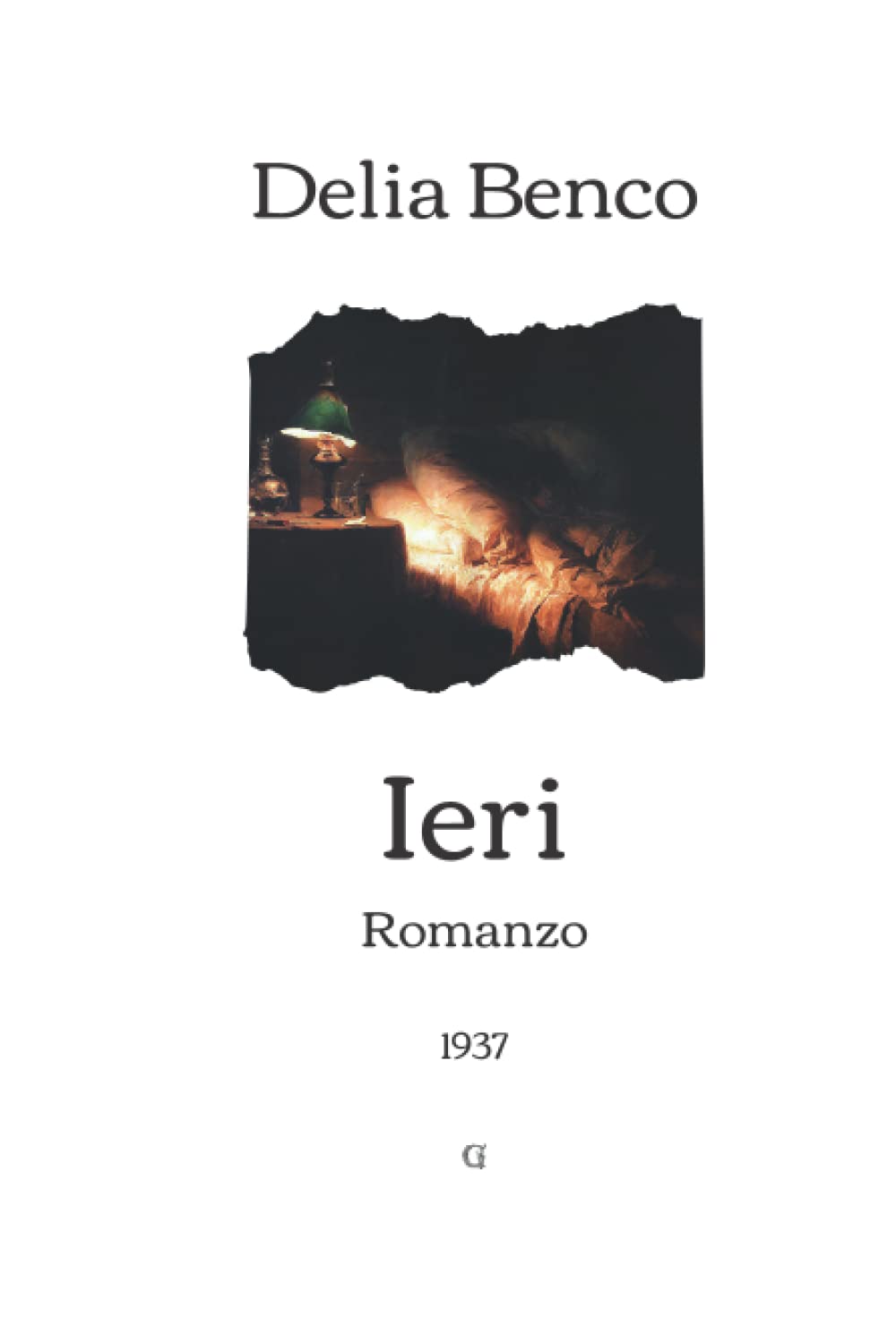
Inizio questo lavoro con un dubbio (del tutto lecito in verità): ma le scrittrici della nostra letteratura, quando non erano del tutto accettate, lo erano invece per una sorta di “ritrosia” personale, chiamiamola così invece di una definizione più corposa e “soddisfacente”?
Meglio chiarire, partendo da lontano (nemmeno tanto rispetto a chi andiamo a considerare): Sibilla Aleramo (che nei nostri classici ancora non abbiamo considerato), per esempio fu o non fu una pedina importante nella nostra narrativa (al di là di chi le stava accanto)? E passerei oltre: Alba De Cespedes (che invece abbiamo già trattato) avrebbe scritto i suoi libri, tra l’altro con grande successo, (Nessuno torna indietro per esempio alla diciassettesima edizione il regime fascista si sentì in dovere di censurarlo, perché scomodo: cosa accidenti erano quelle donne che farfugliavano di libertà dai maschi, che erano madri senza essere sposate e che reclamavano una sacrosanta dignità? Ben lontane dunque dall'immagine delle 'figlie della lupa') solo con l’idea di racimolare soldi invece che sbandierare impulsi libertari?
E Dacia Maraini? Che tra l’altro esordì in un periodo poco adatto alle convenzioni, cosa poteva insegnarci dell’analisi spregiudicata dei meccanismi di convivenza familiare, del processo graduale della consapevolezza che una ragazza assume non solo attraverso riflessioni ma attraverso esperienze crude realmente compiute sulla propria pelle e soprattutto dell’uso di un linguaggio esplicito (ci riferiamo sempre all’unico romanzo che finora abbiamo trattato nel nostro studio su “I classici”: L’età del malessere)?
E chiuderei, molto approssimativamente, questo rapidissimo elenco, con una scrittrice a me personalmente cara: Fausta Cialente. Pensate forse che le sue accuse e la sua prospettiva ideologicamente europea era solo un vero e proprio atto d’accusa contro i nostri governanti e non, forse, un’accusa contro un intero sistema sociale? (Anche lei trattata da noi e in questo caso col romanzo Le quattro ragazze Wieselberger).
Ecco, le nostre scrittrici erano queste (per carità, l’elenco sarebbe ancora più lungo e retroattivamente datato). E soprattutto quello che intendevano comunicare.
Ma Delia Benco invece cos’era?
Detta così sembra quasi un’offesa nei confronti della scrittrice triestina. Ma noi cerchiamo, anche questa volta, di chiarirci meglio. All’epoca in cui nacque Delia, la famiglia de Zuccoli (il vero cognome, diventò Benco quando sposò lo scrittore Silvio) era nel mirino della polizia austriaca a causa di uno zio di Delia che era amico di Guglielmo Obersan, che era un patriota irredentista italiano. Pur sottoposta a continue perdite affettive (sua madre Elvira morì di tubercolosi e il fratello, giornalista e disegnatore satirico, morì poco più tardi dello stesso male della madre) non si diede per vinta e consapevole delle sue capacità, nel 1906 incontrò Silvio Benco, nella redazione in cui lavorava l’uomo, per fargli conoscere i suoi scritti.
In realtà, oltre a qualche racconto, l’unico testo pubblicato dalla Benco è questo Ieri che però vede la luce solo nel 1937 per le edizioni Ceschina. Il libro racconta l’infanzia, l’adolescenza e la maturità della donna e soprattutto gli incidenti che le accaddero (la morte della madre e del fratello).
Quello che non convince nella struttura del romanzo (e che spiega la lunga introduzione che ho fatto) è che il suo essere donna è sempre un passo indietro rispetto alle convenzioni sociali. Non solo, questa arretratezza sociale la Benco l‘avverte, senza però superarla, anche nella fase iniziale della sua vita, quando, per esempio, comincia a suonare il piano… Aizzante dunque sì, la musica, immediata suscitatrice d’intimi ritmi più accelerati, spesso ubriacanti, ma che non aveva una sua vita propria, rimanendo sempre in funzione di canevaccio per lavorarci sopra, non indispensabile oltre tutto, da poterne fare aa meno senza sacrificio.
Oppure, più avanti, in uno serrato colloquio dice: Il tuo sfogo di prima, sai cosa conteneva? Me lo lasci dire? Molta più dose d’orgoglio che di umiltà. Come se l’orgoglio non fosse parte costituente di una donna.
Il romanzo, pur se non tragico e compromettente, visti i disastri che si avvicendano, si conclude con la morte del giovane fratello, anche se le parole non riescono mai ad essere al di sotto di una tragedia infinita.
Delia Benco morirà il 18 agosto 1949 pochi mesi dopo la morte di suo marito, Silvio Benco.
L’edizione da noi considerata è:
Delia Benco
Ieri
Amazon G
Meglio chiarire, partendo da lontano (nemmeno tanto rispetto a chi andiamo a considerare): Sibilla Aleramo (che nei nostri classici ancora non abbiamo considerato), per esempio fu o non fu una pedina importante nella nostra narrativa (al di là di chi le stava accanto)? E passerei oltre: Alba De Cespedes (che invece abbiamo già trattato) avrebbe scritto i suoi libri, tra l’altro con grande successo, (Nessuno torna indietro per esempio alla diciassettesima edizione il regime fascista si sentì in dovere di censurarlo, perché scomodo: cosa accidenti erano quelle donne che farfugliavano di libertà dai maschi, che erano madri senza essere sposate e che reclamavano una sacrosanta dignità? Ben lontane dunque dall'immagine delle 'figlie della lupa') solo con l’idea di racimolare soldi invece che sbandierare impulsi libertari?
E Dacia Maraini? Che tra l’altro esordì in un periodo poco adatto alle convenzioni, cosa poteva insegnarci dell’analisi spregiudicata dei meccanismi di convivenza familiare, del processo graduale della consapevolezza che una ragazza assume non solo attraverso riflessioni ma attraverso esperienze crude realmente compiute sulla propria pelle e soprattutto dell’uso di un linguaggio esplicito (ci riferiamo sempre all’unico romanzo che finora abbiamo trattato nel nostro studio su “I classici”: L’età del malessere)?
E chiuderei, molto approssimativamente, questo rapidissimo elenco, con una scrittrice a me personalmente cara: Fausta Cialente. Pensate forse che le sue accuse e la sua prospettiva ideologicamente europea era solo un vero e proprio atto d’accusa contro i nostri governanti e non, forse, un’accusa contro un intero sistema sociale? (Anche lei trattata da noi e in questo caso col romanzo Le quattro ragazze Wieselberger).
Ecco, le nostre scrittrici erano queste (per carità, l’elenco sarebbe ancora più lungo e retroattivamente datato). E soprattutto quello che intendevano comunicare.
Ma Delia Benco invece cos’era?
Detta così sembra quasi un’offesa nei confronti della scrittrice triestina. Ma noi cerchiamo, anche questa volta, di chiarirci meglio. All’epoca in cui nacque Delia, la famiglia de Zuccoli (il vero cognome, diventò Benco quando sposò lo scrittore Silvio) era nel mirino della polizia austriaca a causa di uno zio di Delia che era amico di Guglielmo Obersan, che era un patriota irredentista italiano. Pur sottoposta a continue perdite affettive (sua madre Elvira morì di tubercolosi e il fratello, giornalista e disegnatore satirico, morì poco più tardi dello stesso male della madre) non si diede per vinta e consapevole delle sue capacità, nel 1906 incontrò Silvio Benco, nella redazione in cui lavorava l’uomo, per fargli conoscere i suoi scritti.
In realtà, oltre a qualche racconto, l’unico testo pubblicato dalla Benco è questo Ieri che però vede la luce solo nel 1937 per le edizioni Ceschina. Il libro racconta l’infanzia, l’adolescenza e la maturità della donna e soprattutto gli incidenti che le accaddero (la morte della madre e del fratello).
Quello che non convince nella struttura del romanzo (e che spiega la lunga introduzione che ho fatto) è che il suo essere donna è sempre un passo indietro rispetto alle convenzioni sociali. Non solo, questa arretratezza sociale la Benco l‘avverte, senza però superarla, anche nella fase iniziale della sua vita, quando, per esempio, comincia a suonare il piano… Aizzante dunque sì, la musica, immediata suscitatrice d’intimi ritmi più accelerati, spesso ubriacanti, ma che non aveva una sua vita propria, rimanendo sempre in funzione di canevaccio per lavorarci sopra, non indispensabile oltre tutto, da poterne fare aa meno senza sacrificio.
Oppure, più avanti, in uno serrato colloquio dice: Il tuo sfogo di prima, sai cosa conteneva? Me lo lasci dire? Molta più dose d’orgoglio che di umiltà. Come se l’orgoglio non fosse parte costituente di una donna.
Il romanzo, pur se non tragico e compromettente, visti i disastri che si avvicendano, si conclude con la morte del giovane fratello, anche se le parole non riescono mai ad essere al di sotto di una tragedia infinita.
Delia Benco morirà il 18 agosto 1949 pochi mesi dopo la morte di suo marito, Silvio Benco.
L’edizione da noi considerata è:
Delia Benco
Ieri
Amazon G
CERCA
NEWS
-
19.02.2025
Il ramo e la foglia edizioni
"La mula e gli altri. Faccende semiserie di provincia”, di Alessandro Conforti. -
19.02.2025
Adelphi
Un altro grande Simenon -
19.02.2025
Ponte alle Grazie
Lisa Ginzburg
RECENSIONI
-
Richard Ford
Per sempre
-
Alessandro Barbero (Tradotto e presentato da)
La voglia dei cazzi
-
Antonio Scurati
L'ora del destino
ATTUALITA'
-
Stefano Torossi
Ottorino Respighi
-
Stefano Torossi
Domenico Cimarosa
-
La redaziione.
Siamo tornati
CLASSICI
CINEMA E MUSICA
-
marco minicangeli
Una barca in giardino
-
Marco Minicangeli
La gita scolastica
-
Marco Minicangeli
Juniper - Un bicchiere di gin
RACCONTI
-
Sara Calzolari
Quella volta il vento...
-
Ersilia Tomoe
L'appartamento
-
Simone Severini
Celacanto

